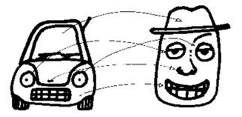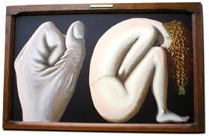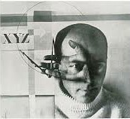Politecnico di Milano, Anno Accademico 2012-2013
Cattedra di FOOD-DESIGN.
(Seconda esercitazione, mercoledì 13 marzo 2013)
***
A building/a meal: analogies.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, / Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes / Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes, / Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles; / I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles / Dans la colère ou les ivresses pénitentes; / U, cycles, vibrements divins des mers virides, / Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides / Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux; / O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, / Silence traversés des Mondes et des Anges: / – O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux!
Voyelles, Arthur Rimbaud 1871.
Alexandre Balthasar Laurent Grimod de La Reynière (1759-1837), parigino di nascita, è il padre e l’inventore della “scrittura gastronomica”. Si vantava di aver ereditato dalla famiglia una piccola fortuna e un grande appetito con i quali realizzò molti dei suoi sogni e si costruì una solida fama di gourmet.
Divenuto avvocato cominciò a patrocinare, per principio, le cause della povera gente, insofferente alle tradizioni scrisse un libello contro la nobiltà, fu espulso dalla professione. Ci rimase male, ma questo episodio gli salvò la testa durante la Rivoluzione Francese.
Amava accompagnarsi ai filosofi e alla gens de lettres, i suoi déjeuners bihebdomadaires divennero una tradizione nei salotti parigini.
Il 1 febbraio del 1783 organizzò una cena per diciassette amici convocati con un biglietto listato a lutto. Voleva dimostrare che si poteva essere filosofi e materialisti, per l’occasione regalò ai suoi ospiti il suo ultimo libro, Réflections philosophiques sur le plaisir. Par célibataire.
Amava i banchetti a tema soprattutto quelli “archeologici” con pasti che imitavano gli antichi baccanali. Nonostante alcuni gravi handicap fisici ebbe una vita con molte avventure, compreso il carcere e l’esilio. Rischiò anche di finire in manicomio.
Sotto il Consulat inizia la pubblicazione di L’Almanach des Gourmands, una guida gastronomica per gli appassionati della cucina. Il successo fu enorme e la piccola storia racconta che se ne approfittò per “minacciare” con i suoi giudizi ristoratori, pasticceri e cuochi.
Nel 1808 diede alle stampe il Manuel des amphitryons. È un libro brillante e arguto. In esso il suo autore mescola l’arte della tavola, al teatro e all’architettura. “Luoghi” in cui regnano la commoditas e la voluptas, come già qualche secolo prima aveva scritto Leon Battista Alberti.
La Reynière espone e definisce il pasto come l’architettura di un palazzo suntuoso dove ciascun servizio ne costituisce un elemento. Leggiamo.
“ Il potage sta a una cena come il portico o il peristilio a un edificio. Vale a dire non solo è l’entrata del pasto, ma deve essere progettato in modo di dare un idea di ciò che seguirà. Esattamente come in un’opera comica l’ouverture deve annunciarne il soggetto. Le entrate formano il primo piano e gli appartamenti più importanti. A questo proposito gli Hors–d’oeuvre, come piccoli cabinets o boudoirs, valorizzano i piatti più importanti e li completano. Possiamo anche dire che l’arrosto rappresenta il salone d’onore, la stanza principale, quella in cui si concentra l’orgoglio del proprietario, quella che meglio ha decorato. Un luogo destinato a ricevere gli ospiti importanti, con l’arredo più bello. Gli entremets, invece, vanno equiparati agli attici, hanno il soffitto basso, non sono grandi ma decorati con estrema eleganza. Le salse infine costituiscono i mobili senza i quali gli appartamenti sarebbero disabitati”. (Potpourri tratto dagli scritti di La Reniére)
Per il senso comune l’analogia è la somiglianza tra due cose.
Gli scolastici dicevano che con essa era possibile pensare una relazione tra gli essere designati con un nome comune. Relazione che aveva ai suoi estremi l’equivocità e l’univocità.
Nel contesto della nostra esercitazione definisce la messa in relazione di circostanze appartenenti a domini diversi della realtà in modo che sia possibile stabilire delle corrispondenze entro queste circostanze.
Per esempio Platone costruisce un’analogia tra le tre parti dell’anima – la ragione, il coraggio, il desiderio – e le tre classi della città ideale – il re-filosofo, i suoi guardiani, i produttori – perché per questo filosofo l’anima è nel piccolo quello che la città e nel grande. Nel ‘600 il medico inglese William Harvey stabilì un’analogia tra il cuore è la pompa. Descartes – Cartesio – pressappoco negli stessi anni elaborò un’analogia tra i suoni e i colori. Ernest Rutherford a cavallo tra 800 e 900 vide un’analogia tra l’atomo e il sistema stellare.
L’analogismo – insieme alla deduzione e all’induzione – è una delle più importanti forme di ragionamento. Con essa si stabiliscono dei rapporti tra domini diversi della realtà sia per illustrare una tesi che per scoprirne uno sconosciuto.
***
Scopo dell’esercitazione è quello di stabilire una relazione analogica tra il luogo in cui abitiamo e le nostre abitudini alimentari. In altri termini. Come il luogo che abitiamo può essere “narrato” dalla forma di cibo? Come dice La Reynière, è l’arrosto che “incarna” il salotto buono di casa? C’è una relazione tra l’interno del nostro frigorifero e l’appartamento che abitiamo?
L’elaborato può essere sviluppato con il mezzo espressivo che si ritiene più opportuno, fotografia, disegno, fumetto, collage, rappresentazione elaborata per via elettronica.
L’elaborato dovrà essere presentato stampato su un foglio A3.
(Per meglio sviluppare l’obiettivo di questa esercitazione suggeriamo agli studenti di cliccare in rete “figure retoriche”. )
**************