Racconti gourmand. Dodici.

Venivano da Tarragona ed erano diretti a Faido nella Svizzera italiana, emigrati già da molti anni. Quando entrai a Genova nello scompartimento dov’erano accampati viaggiavano, come appresi in seguito, da più di dieci ore. Il treno era semi vuoto, mi accomodai vicino al finestrino senza prestare loro attenzione. Ero adirato. Non solo non ero riuscito a riscuotere un credito che vantavo già da un anno da un collezionista, ma la visita di cortesia a cui mi aveva indotto un amico nella casa-bottega di una gallerista, che mi era stata presentata come interessata a Fluxus, mi aveva basito. Di questa avanguardia – con la quale vantavo una decennale confidenza e che in qualche modo, dopo avervi aderito, avevo promosso in numerose mostre e concerti – conosceva poco e non ne capiva niente. Mescolando l’eloquio con un “pretto favellare francioso”, come avrebbe detto il Foscolo, che la rendeva ridicola, l’unica cosa che la legava a Fluxus era l’amicizia con alcuni suoi personaggi minori. Ogni avanguardia li ha, come i cani hanno le pulci. In Italia, soprattutto se possiedono un passaporto americano, riscuotono sempre un grande successo. Legionari in terra di colonia arraffano quello che possono e lasciano in loco opere che in molti casi non sono altro che deiezioni di cui altrove si vergognerebbero. Di Maciunas spendono il nome senza averne mai condiviso né la poetica, né la cultura. In particolare ne disprezzano, perché lo temono, il progetto politico, ma non se ne preoccupano, basta loro per tirare a campare il narcisismo che esibiscono e l’opportunismo che mascherano. In questo clima, verso la fine dell’incontro come un’oca giuliva questa gallerista si mise a parlare di progetti e d’iniziative tra le quali ce n’era una in corso e mi chiese se volevo aderirvi. Incuriosito chiesi delle spiegazioni, la proposta era questa: prendere delle cravatte qualunque e dipingerci sopra in modo da rivenderle come “cravatte Fluxus”. Sorridendo aggiunse che aveva molti collezionisti per queste “opere portatili” che facevano la fila alla sua porta. L’assurdità delle situazioni spesso rende prudenti. Borbottai che ci avrei pensato e ci congedammo. Questo in breve lo stato d’animo con cui ero salito sul treno alla stazione di piazza Principe per tornare a Milano maledicendo il mio insegnante di storia dell’arte che con la sua autorevole saggezza e il grande amore per la pittura moderna aveva rovinato la mia vita che una tradizione familiare destinava da generazioni all’industria o alla politica.

Vuole farci compagnia? Eravamo rimasti in tre nello scompartimento. Mi aveva rivolto l’invito quello più anziano, l’altro stava tirando fuori da un enorme borsone una marmitta avvolta in un grande tovagliolo a quadrettini rossi. Senza attendere una mia risposta mi porsero un piatto di legno con una grossa fetta di pane bagnato sulla quale troneggiavano due salsicce, una sardina, un uovo sodo, dei ceci, delle fette di peperone rosso cotte alla brace e uno verde crudo, un chorizo, paprika. Un piatto che profumava di aglio e di cultura contadina. Mentre imbarazzato cercavo di capire quello che avrei potuto assaggiare senza offendere i miei due ospiti, tagliarono un melone e me ne offrirono una fetta. Si mangia tutto insieme sentenziò il più anziano dei due, è un piatto del mio paese. Sospirò. Adesso lavoriamo in fabbrica, ma siamo pastori e siamo anárquicos. Sobbalzai, l’aveva detto in spagnolo e a bassa voce, ma guardandomi negl’occhi. Inghiottii un pezzo di peperone per prendere tempo e poi risposi, allora siamo in tre a ricordare il compañero Durruti. Il più giovane mi corresse, un hermano, un hermano por nosotros. L’altro si asciugò una lacrima e con gesti bruschi tirò fuori da una sacca una bottiglia di Clos Monlleó. Brindiamo, disse, è un ottimo vino, non possiamo permettercelo, ma questa bottiglia l’abbiamo rubata.
Si sa come finiscono certe cose. Mangiammo tutto e ci scolammo due bottiglie, poi i miei due nuovi amici cominciarono a cantare canzoni partigiane. L’addio alla Centrale di Milano fu doloroso, non ci saremmo mai più rivisti anche se c’eravamo scambiato gli indirizzi. Quando il loro treno sparì nella notte in direzione di Chiasso, stracciai in pezzetti minuscoli il foglietto di carta che mi avevano dato e li gettai in aria. Come farfalle furono risucchiate dalla notte.
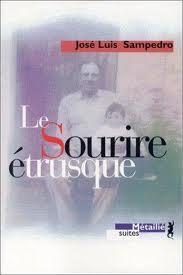
Migas. Il piatto che mi avevano offerto si chiama “migas”, tipico dei pastori spagnoli che lo preparano spesso con gli avanzi. È un piatto della nostalgia e del rimpianto che ha un’origine antica e affonda nella cucina araba e ebraica. L’introduzione della pancetta ne ha fatto un piatto nazionale iberico.
C’è un bel libro che ne parla scritto da José Luis Sampedro, uno scrittore e un economista catalano, il titolo italiano è Il sorriso etrusco e tra le altre cose è ambientato a…Milano.
***
