Gli aforismi di Jean Anthelm (2).
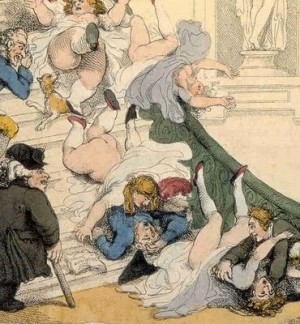
La nostalgia considera leale la tradizione oscurantista del passato, ma questo è un infantilismo rivelatore della paura verso l’industria agroalimentare. Compone il sillogismo per cui se c’è questo è necessariamente a causa di quella. Così il fascino di Cuccagna illude su un possibile ritorno della tradizione, questo fascino inganna due volte, sul fatto che sia possibile e che non rappresenti un espediente delle ideologie reazionarie per dare un senso attraverso i cibi ai loro inganni.
Le grandi multinazionali del cibo sono la prova del fallimento delle espressioni nazionali della sovranità, che si è rifugiata nei localismi.
I localismi alimentari hanno alle spalle anche altre nostalgie, quelle di una letteratura dialettale, di una valorizzazione del folclore e della decentralizzazione, degli spettacoli storici, del paesaggio museo.
Il lavoro dei laboriosi pretende sempre un contenuto morale…
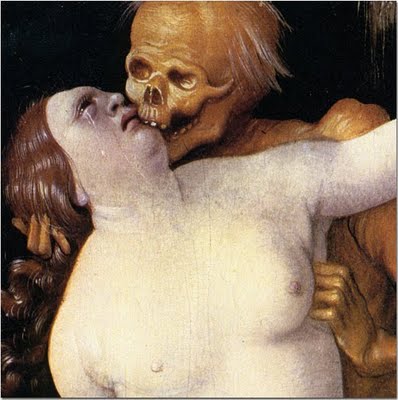
È la metafisica del vino che disegna le qualità materiali del territorio aureolandoli di virtù.
Non c’è il mito del territorio nella cucina medioevale, di contro c’è una pletora di ricette nell’ortografia della nostalgia: la specificazione presuppone l’identità e il commercio.
La frugalità è una condanna, la rusticità è un carcere nel quale un pane bigio s’inzuppa in un broda lardosa. Occorre confondere la frugalità con la moderazione per far si che il mondo agricolo incarni il paradiso perduto.

Il vino un tempo provocava il furor, oggi la rassegnazione, scoprono le sostanze psicotrope solo i popoli e le culture che le cercano, ma ogni popolo o ogni cultura cerca quelle che gli sono più congeniali…il motivo è facile da intuire, devono convivere con le loro epifanie.
Le sostanze che modificano l’NSC (normal state of consciouless ?) sono molte, esse possono indurre all’atarassia come l’oppio, alla frenesia come l’iboga, all’euforia come l’hascich o alle allucinazioni come il peyotl, solo l’alcol spinge alla rassegnazione, in arabo al kohl è un’espressione che serve ad indicare sia lo spirito del vino che il fard per abbellire gli occhi: metonimia, sguardo, speranza…
Le sostanze psicotrope acuiscono il “vedere”, fanno viaggiare nello spazio, nel tempo, nella coscienza, insegnano delle tecniche, guariscono. Il vino invece vi porta subdolamente ad un bivio: da una parte c’è l’oblio, dall’altro la speranza. Due forme di accecamento.
Le pratiche agricole e cucinarie sono consolatorie perché implicano un fine e possono comprendere dei valori.

Solo parlare di concezione della natura significa inoltrarsi in qualcosa di osceno. Le costruzioni nostalgiche hanno il merito di comprendere le rappresentazioni della natura e dare loro un senso. La natura, come la coscienza, investe i modi di pensare e le forme dell’affettività, essa è dapprima amore e poi nostalgia.
Non c’è nostalgia dei luoghi che non sia, sotto la patina della commozione, un rimpianto materno.
La natura è un insieme di parti-spettacolo che sembrano tra di loro connesse dal bisogno, dalla gerarchia, dal gusto, dai pregiudizi e soprattutto dai fantasmi materni.
Le relazioni dell’uomo con la natura sono, nella sostanza, storiche. Contribuiscono a definire le epoche e i paradigmi con i quali essa diviene trascendentale…
Nel candore del mattino c’è il sacro senza ombre, il naturale senza artifici, il divino come senso del luogo.
Come il cielo è attraversato da segni il cui senso è nei gabinetti dell’astrologo, così la madre terra è un’idea la cui fisionomia appare sui banchi dei supermercati delle città.
La sacralità dei localismi vede negli animali una risorsa biologica, ma non esita a farla a pezzi per meglio infilzarla negli spiedi della tradizione, del resto, il paradiso della salsiccia è una perversa simbiosi in cui la nostalgia delle origini si coniuga con l’argilla delle paure.
Se abitare è sentirsi ovunque come a casa propria siamo stranieri davanti alla natura che ci costringe ad inventarla. Non basta una tavola per fare un festino, non basta l’idea di alimento per fondare una gourmandise.

Nei localismi alimentari l’unica cosa che ci mette la natura è lo spazio in cui inventarla come una
continuità espressiva tra la terra e le l’artificio.
Un tempo era la città ad eleggere le specialità dello spazio rurale, riconoscendole. Così il prosciutto divenne di Parma. Oggi è il marketing, anche in considerazione del fatto che la giustificazione naturale deve cedere necessariamente il passo al carattere acquisito del gusto. Un arbitrio che trasforma il ritorno al territorio in un affare. Alla fine, la “gastronomia” è un codice o, più precisamente un topos e non un sistema.
Le culture locali sono, da un punto di vista fenomenologico, degli orti cintati contro le intrusioni barbariche, ma la loro efficacia è politica, come tutte le costruzioni morali che non diventano rivoluzioni. Tuttavia la nostalgia che le anima non può mai compiersi politicamente per il fatto che essa è efficace solo nella forma di un eterno ritorno che la tradizione coltiva.
Davanti ai capricci della storia il gusto appare come un ordine immutabile, ma la sua qualità, nella modernità, sta nella erodibilità che la forma di capitale esuma. Del resto, che la tradizione sia vulnerabile al progresso la dice lunga sulla fungibilità dei valori.
La nostalgia è una regressione materiale in nome della morale assoluta esattamente come il progresso è – prima di apparire un vantaggio materiale – una religione senza ethos.
I procedimenti meccanici e chimici di produzione del cibo e il modo di “assorbirlo” parlano di una stagione di fami e di carestie altrettanto vivace di quella in cui questi stessi procedimenti, ritenuti eccessivi, radicalizzano la loro recriminazione.
Su questo versante la nostalgia coltiva scenari oscuri nella loro semplicità e moltiplica i dettagli più infimi, tali che ogni minimo scarto rispetto alla doxa imperante appaiono subito come catastrofici ed immorali. Non bastano i sapori ritrovati per ricomporre le integrità perdute.
Accusare il progresso nell’ambito dell’agro-alimentare di tutti i mali dell’industrializzazione significa tutt’al più rendere il suo entusiasmo colpevole, senza minimamente colpire ciò che ha demolito tradizioni millenarie.
Non per caso si mira alla sensibilità del pubblico – paventandogli una dieta a base di tavolette azotate – piuttosto che alla sua educazione, nonostante le interessate smentite.

Bisognava amare l’idea di progresso, come fa Nicolas L. Sadi Carnot, per poterla disprezzare alla stregua di una fede.
Tra la natura di per sé e la natura dell’uomo c’è la transustanziazione della parola e il sacrificio delle esigenze epistemologiche, del resto lo dovevamo capite, la rinuncia al frigorifero è il passo di esordio per ritrovare il gusto della carne falsificato dalle tensioni tra il candore del territorio e la potenza dell’industria. Ma non è tutto, e se avesse ragione Leon Daudet nell’affermare che è la famiglia il baluardo contro la scienza?
