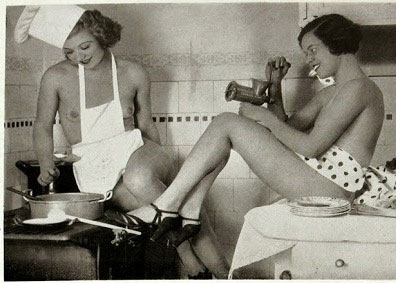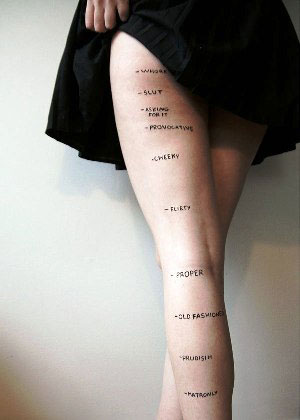Parte prima.
IED
Laboratorio di antropologia culturale. Esercitazioni di adhocism e bricolage.
“Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati ma, a differenza dell’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie prime o di arnesi, concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto: il suo universo strumentale è chiuso e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè ad un insieme via, via “finito” di arnesi e materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di questo insieme non è in rapporto col progetto del momento, né d’altronde con nessun progetto particolare, ma è il risultato contingente di tutte le occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui di costruzioni o di distruzioni precedenti. […] Il suo modo pratico di procedere è inizialmente retrospettivo: egli deve rivolgersi verso un insieme già costituito di utensili e di materiali, farne o rifarne l’inventario, e infine, soprattutto impegnare con esso una sorta di dialogo per inventariare, prima di sceglierne una, tutte le risposte che l’insieme può offrire al problema che gli vien posto.”
C. Lévi-Strauss, 1962, La pensée sauvage, Plon, Paris, trad. Il pensiero selvaggio, Il saggiatore, Milano 1964, pp.30-31
Premessa. In questo contesto va da subito chiarito che l’adhocism è solo una particolare variante del bricolage, è nata nella California della controcultura (counterculture o dell’underground culture) e legata soprattutto al design e all’architettura o, meglio, all’attività dei designer e degli architetti.
In rete si trovano molte sintesi metodologiche del manifesto dell’adhocism scritte negl’anni della hippy generation, questa in dieci punti mi sembra la migliore.
Leggiamola prima di proseguire.
1. Se la necessità è la madre dell’invenzione e i sistemi precedenti sono il padre, l’adhocism è il loro frutto creativo.
2. In genere, nella cultura la spiegazione procede con un metodo che assomiglia molto a un procedimento di adhocism, che possiamo definire di ricognizione.
3. L’adhocism è lo stile di chi grida eureka. Vale a dire di chi inventa e non progetta.
4. Politicamente parlando l’adhocism è democratico e pragmatico, come sono le prime fasi di ogni processo rivoluzionario.
5. Anche nell’adhocism si può tendere all’efficienza e alla perfezione, perché non è necessario né si può rinunciare alla bellezza.
6. L’adhocism mal fatto è solo un pigro mettere insieme di cose diverse. Si ruba dalla banca delle idee del mondo, non paga nulla e si svaluta la moneta creativa. I designer lo chiamo bad design e ne hanno fatto una corrente progettuale.
7. L’adhocism tende ad essere aperto – o, meglio, una struttura aperta – come sono gli aggiornamenti di una enciclopedia, oggi diremmo di un sito.
8. Se usare un coltello come cacciavite è un adhocism perdonabile, ma ricordatevi che il coltellino svizzero è la sua misura evolutiva.
9. Non dimenticare che anche gli organismi e i congegni più semplici sono il frutto delle diverse unità che li compongono.
10. Sulla terra tutto deriva da qualcosa d’altro.
Di contro, il bricolage e il bricoleur sono figure archetipiche di un certo modo di pensare la techne, cioè la pratica creativa, e, di riflesso, le arti, anche se, nell’accezione comune, il bricolage identifica il fare piccoli lavori manuali.
Nel Pensiero selvaggio (1962) Claude Lévi-Strauss scrive:
“Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati, ma diversamente dal progettista, egli non li subordina al possesso di materie prime e arnesi, concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto.
Il suo universo strumentale è chiuso e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre a ciò che dispone, cioè, a un insieme via, via finito di arnesi e di materiali, per altro eterocliti, strani e diversi, dato che la composizione di questo insieme non è in rapporto con il progetto del momento, né con nessun progetto in particolare, ma è il risultato contingente di tutte le occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti…”.
Per Lévi-Strauss i meccanismi del pensiero sono un attributo comune a tutti gl’uomini, ma non si manifestano nello stesso modo, perché dipendono sia dalle necessità immediate che dai problemi della produttività.
La novità di questo capolavoro dello strutturalismo consiste nel dimostrare che c’è poca differenza tra il pensiero dei cosiddetti primitivi e il pensiero moderno, pertanto è sbagliato affermare che il pensiero moderno si distingue da quello primitivo per la sua capacità di apprendere la complessità.
Agendo per distinzioni e contrapposizioni il pensiero selvaggio costruisce degli edifici mentali che gli facilitano la comprensione del mondo e indipendentemente dai sistemi che costituiscono il pensiero della scienza.
Il pensiero selvaggio, dunque, non è il pensiero dei selvaggi, ma il pensiero allo stato originario che si distingue dal pensiero coltivato.
In breve, il pensiero selvaggio è complesso esattamente come il pensiero scientifico e si distingue da questo perché affronta direttamente la complessità senza ricorrere a delle teorie che si prefiggono di sostituire, utilizzando delle figure logiche, delle complessità comprensibili a quelle che lo sono meno o non lo sono affatto.
Il pensiero selvaggio, in altri termini, si prefigge di guardare il mondo in modo concreto, mentre il pensiero scientifico lo affronta in modo astratto, entrambi tendono allo stesso risultato e non è vero affatto che il primo sia una sorta di balbuzie dell’altro.
Lévi-Strauss, in pratica, distingue tra il savant (lo scienziato) e il bricoleur per le funzioni inverse che, nell’ordine strumentale e finale, essi assegnano all’avvenimento e alla struttura.
Uno, infatti, porta alla luce gli avvenimenti attraverso le strutture, l’altro, il bricoleur, le strutture attraverso gli avvenimenti.
In questo quadro la figura dell’artista è in mezzo, perché egli tende a confezionare con mezzi artigianali un oggetto materiale che è allo stesso tempo un oggetto di conoscenza.
Ma perché ci occupiamo del modo di fare dei bricoleur?
Semplicemente perché rispetto al lavoro scientifico classico il design sta sempre di più dalla parte del bricoleur.
Non per caso il design è pervasivo, cioè penetra dappertutto nella fase di progettazione creativa.
Meglio, nel design utilità e estetica si intrecciano in un processo di progettazione, ma quello che è rilevante che non sempre è chiaro in che modo questo incontro avviene.
Il fatto che il bricoleur opera con ciò che ha sotto mano lo rende diverso anche dal tecnico, se non altro perché è costretto a ripensare in continuazione ai mezzi che ha a sua disposizione.
Dunque:
Il bricoleur immagina e l’immagine è un oggetto concreto.
Lo scienziato invece parte dai concetti che sono entità astratte.
Dicendo che il bricoleur immagina diciamo che riorganizza in continuazione ciò che ha disposizione.
Cosa vuol dire?
Che il bricoleur usa i segni e non i concetti, che è in un continuo dialogo con i materiali che sono la ragione delle sue decisioni.
Egli procede facendo e rifacendo in continuazione il punto della situazione, perché sa di essere in balia delle circostanze e, così operando, in qualche modo “firma” (personalizza) ciò che fa.
Queste osservazioni, se le consideriamo con attenzione, avvicinano – come abbiamo visto – il bricolage a l’arte, soprattutto all’arte non accademica, in particolare a quella di molte avanguardie del ventesimo secolo e, più vicino a noi, a molte esperienze della cosiddetta arte povera, minimalista o di chi usando le rovine del mondo moderno porta loro a una nuova vita, come si legge nel catalogo della mostra newyorkese, American Bricolage di qualche anno fa.
Il bricolage è implicito anche in molte forme di progettazione in cui è necessario rispettare la tradizione o costruire con i materiali in loco.
In questo caso si preferisce parlare di progettazione consapevole o di effetto della tradizione.
Possiamo comprendere meglio il modo di operare del bricoleur anche da un’altra prospettiva, confrontandolo con presupposti della teoria della dissonanza cognitiva elaborata dal sociologo psicologo americano, Leon Festinger, è stato un allievo di Kurt Lewin e a insegnato alla New School for Social Research di New York, dove ha insegnato a fianco di Salomon Asch.
Per Festinger gli individui sono sensibili alle incongruenze tra le azioni e le convinzioni.
Queste incongruenze spingono l’individuo a risolverle o cambiando la propria opinione, o cambiando il modo di procedere o ridefinendo le azioni sulla scorta dell’esperienza.
Apriamo a questo punto una breve parentesi su alcuni concetti o metodi che in qualche modo sono legati all’adhocism.