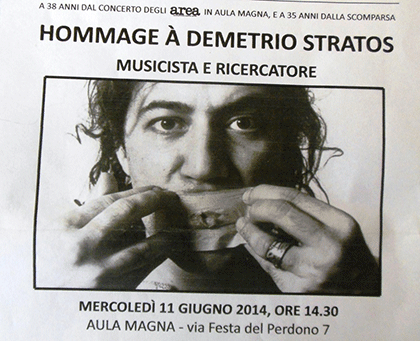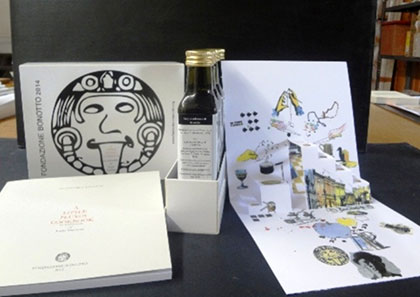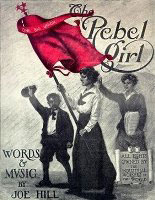CON.NEXIONI 3

Le istituzioni artistiche da una parte sono funzionali alla gestione del potere diffuso della società mercantile, dall’altra concorrono a togliere ogni autorità alle strutture classiche del gusto. In altri termini sono in grado di conciliare le forme del potere immateriale all’estetizzazione delle merci culturali.
Me lo ha chiesto un vecchio geometra di paese. Ma sul serio nessuno ha mai pensato di fucilare Albert Speer, neppure dopo la pubblicazione delle sue memorie?
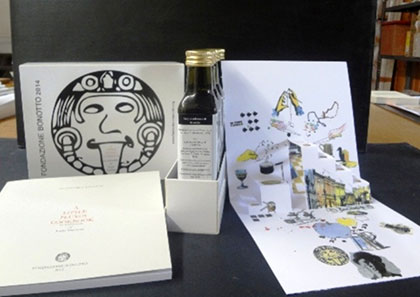
Arte nell’arte. Le istituzioni come api costruiscono e ricostruiscono incessantemente il gigantesco trompe-l’oeil dello spettacolo su cui muovono il polline dell’arte moderna e fanno sfoggio massonico di operosità.
Paradossi. Un’avanguardia cessa di essere un’avanguardia se è influenzata da quelle che l’hanno preceduta. Meno nell’arte moderna.
Piuttosto che sfidare l’ana-estetica della modernità gli artisti si adoperano – come si dice a Parigi – a promuovere la dissolution des frontières entre l’art e la vie. Cosa aggiungere? Il libero mercato rende liberi.
L’attività espositiva delle istituzioni fa passare in secondo piano l’interesse per il contesto sociale della produzione, della circolazione e della fruizione dell’attività artistica. Eppure l’arte moderna viene da esse considerata più come un sistema di azioni destinate a gestire la doxa, dunque, il mercato del gusto, che a favorire i processi di simbolizzazione. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che la critica d’arte costruisca dei congegni narrativi – in continua evoluzione – delle espressioni visuali, congegni dai lessemi abductivi, capaci di trasformare il sistema dell’arte in un immenso spettacolo integrato dalle enormi potenzialità captative. Ma perché darsi tanto da fare? Per trasformare le esperienze sensoriali in estetiche e con esse legittimare ideologie e credenze.

La fascinazione dell’opera d’arte contemporanea è più efficace più si risolve in una provocazione, fino al punto che questa può essere intesa come un “ornamento” necessario. In questo contesto è compito delle istituzioni assicurare dei modelli di culto delle immagini e comporre degli assi di coerenza (Gell) che sappiano governare le relazioni tra gli artefatti. Per conseguire questo risultato ci vogliono le stesse capacità degli equilibristi: far svanire le singolarità formali tra le pieghe delle generalità culturali.
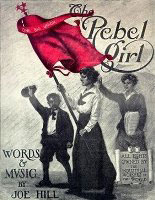
In termini evolutivi l’ornamento come provocazione, lungi da essere rifiutato, è un elemento essenziale per lo sviluppo del gusto e dell’espressione. Anche in questo caso è importante la narrazione critica ai fini di una consequenzialità filologica delle poetiche. La semplicità estetica, di contro, favorisce la provocazione e ingenera l’illusione dell’originalità.
Il “risultato operativo” di una istituzione si misura dall’efficacia delle strategie sociali di esercizio del proprio potere di condizionare il gusto. Una tale capacità di persuasione va esercitata entro dei codici riconoscibili e culturalmente condivisi con i quali si “manifatturano” i souvenir dello spettacolo.

Il più grande delitto contro l’arte è pensare a essa in termini pedagogici e/o educativi, fingendo di ignorare la funzione classista e discriminatoria dell’estetica.
A dispetto delle apparenze le avanguardie sono sempre state piene di educatori e neppure Fluxus ne è immune. Essi campano sui truismi e fabbricano bussole con aghi smagnetizzati.
Per la politica delle istituzioni è meglio l’artista testimonial che l’artista engagée. Semplifica l’uso del non-sense, è come la forbice che taglia il nodo. Questo artista in genere è un minimalista che santifica l’opera a San Euclide.

*****